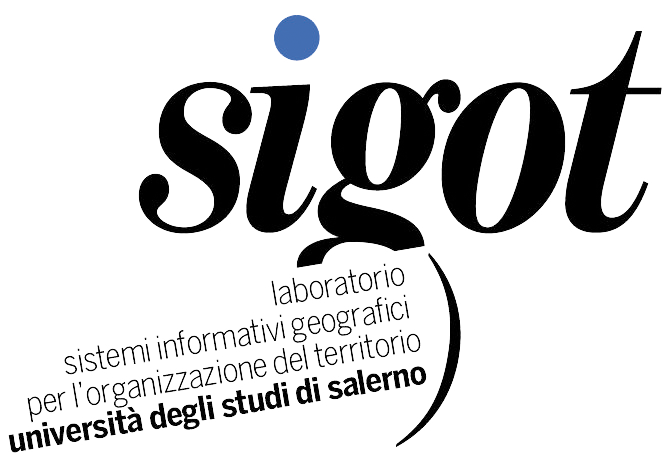Presentazione
Dagli anni della sua fondazione, il Laboratorio SIGOT ha sempre svolto attività di supporto alla ricerca, inizialmente attraverso la progettazione di cartografie tematiche realizzate con sistemi tradizionali e, successivamente, mediante il reperimento e l’utilizzazione di banche dati digitali, il trattamento di cartografia tecnica (ortofoto, fotografie da satellite, carte tecniche regionali, …), la realizzazione di cartografie tematiche georeferenziate alle diverse scale, lo sviluppo di applicativi di Sistemi informativi geografici e WebGIS e, più di recente, l’archiviazione e la digitalizzazione di cartografie storiche.
Visto che non tutte le ricerche e le attività svolte negli anni presso il Laboratorio possono essere qui ricordate, appare opportuno evidenziarne alcune più significative, al fine di tracciare il profilo di una struttura che ha al suo attivo quasi quarant’anni di esperienza.
ATTIVITÀ PRINCIPALI
Anni 80 : supporto alle pubblicazioni della collana “Geografia” dell’Istituto di Geografia e, successivamente, del Dipartimento di Analisi delle componenti culturali del territorio. La collana ebbe vita fino agli anni Novanta e raccolse numerosi lavori quasi tutti supportati da cartografie tematiche (Cataudella, 1983; Riitano, 1983; Cataudella, D’Aponte, Riitano, 1984; Riitano, 1988).
1980 realizzazione di due software didattici, “Sistema Italia” e “Sistema Europa” che, attraverso l’utilizzo del computer, consentivano di consultare una sorta di Atlante appositamente predisposto e di realizzare cartografie tematiche alla scala comunale il primo e alla scala regionale il secondo (Cataudella, 1988 e 1990; Riitano, 1991 e 1994).
Nel 1987, il Laboratorio fu impegnato nella realizzazione di un’opera cartografica importante, l’Atlante tematico della Basilicata, commissionato dalla Giunta regionale e curato da Mario Cataudella. Il lavoro, costituito da 33 tavole con relative schede informative, fu diviso in dieci sezioni, affidate prevalentemente a geografi ma anche a specialisti di altre discipline (Cataudella, 1987) (Le sezioni realizzate furono le seguenti: Immagini del passato (Elio Manzi), Aspetti fisici (Ennio Cocco, Tommaso De Pippo); Aspetti demografici (Domenico Ruocco, Nicolino Castiello); Attività economiche e spazio regionale (Nicolino Castiello, Francesco Citarella, Carmelo Formica, Maria Laura Gasparini, Tullio D’Aponte, Mario Cataudella, Franca Miani, Pasquale Coppola); Centri e sistema insediativo (Lida Viganoni, Carmelo Formica); Trasporti (Carmelo Formica); Servizi, strutture sociali, divisione del territorio (Maddalena Scaramella, Lida Viganoni); Geografia elettorale (Pasquale Coppola); Sistema ricettivo e attività turistiche (Mariagiovanna Riitano); Territorio, archeologia, fatti culturali (Giovanna Greco, Angela Pontrandolfo, Corrado Bucci Morichi, Enzo Spera, Michele Cataudella). ). Gli elaborati, alla scala di 1:500.000 e di 1:1.000.000 furono disegnati a mano, utilizzando una grafica studiata per renderne agevole la lettura. D’altra parte, l’intento della Regione nel promuovere l’iniziativa era quello di diffondere una migliore cultura del territorio attraverso il linguaggio cartografico. L’Atlante ebbe grande successo, fu recensito e presentato in diverse sedi, fra cui quella prestigiosa della Camera dei Deputati, e richiesto alla Regione da molti ambienti educativi. Difatti, alla prima edizione caratterizzata da una veste tipografica ricercata, con singole tavole assemblate in un apposito contenitore, ne seguì una seconda più essenziale e pratica con una tiratura molto alta, così da consentire un’ampia distribuzione dell’opera.
1995: messa a punto del primo Sistema informativo geografico, realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Mario Cataudella e finanziato dal CNR. Utilizzando come riferimento le sezioni di censimento del centro storico di Salerno, il GIS analizzava e rappresentava, nel dettaglio, i servizi commerciali e le caratteristiche socio-demografiche della popolazione. Il lavoro fu citato e ripreso nel Piano urbanistico di Salerno curato da Oriol Bohigas (Cataudella, 1996).
1998, su incarico della Regione Campania, fu realizzata una sperimentazione cartografica per la delimitazione da foto satellitari delle aree percorse da incendi boschivi (Cataudella, 1999).
1999 fu prodotto l’Atlante tematico Scenari socio-demografici delle aree a rischio della provincia di Salerno, finanziato dal Consorzio interuniversitario per la previsione e prevenzione dei grandi rischi (CUGRI) delle Università di Salerno e Napoli. Il lavoro costituì la ricerca di base territoriale per la stesura del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile (legge 224 del 1992), necessaria premessa per la redazione dei Piani di emergenza da parte delle Prefetture (Riitano, 2000).
2000, il medesimo gruppo di lavoro realizzò un GIS sul centro storico di Benevento, cofinanziato dalla Regione Campania sul Piano operativo plurifondo (Cataudella, 2001). Il Sistema informativo consentiva una conoscenza approfondita dell’area in termini di attività commerciali, traffico, accessibilità, tempi di percorrenza, aspetti socio-economici ed evidenze storico-artistiche; fu utilizzato nell’ambito della programmazione urbanistica realizzata dallo studio Zevi-Rossi (Iovino, 2010).
2000: redazione del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Avellino, realizzato per conto della Giunta regionale, che costituì il lavoro preparatorio per la realizzazione del Piano faunistico-venatorio della Regione Campania (Cataudella, 2000). Il Piano, poi trasformato in legge regionale, mise a punto una mappatura delle aree di divieto venatorio.
2000: collaborazione alla stesura del Piano di sviluppo socio-economico della Comunità montana “Penisola Amalfitana”, curato dal Dipartimento di Studi e ricerche aziendali dell’Università di Salerno. Presso il Laboratorio, furono realizzate le cartografie relative all’evoluzione del sistema 1990 (Riitano, 2002).
2004, invece, la ricerca finalizzata all’individuazione e analisi delle strutture dismesse della Costiera Amalfitana e alla messa a punto di un progetto di riqualificazione del ricchissimo patrimonio di edifici protoindustriali abbandonati della Valle dei Mulini di Amalfi e Scala (Riitano Amodio). Per l’occasione, al fine di dare maggiore concretezza all’idea progettuale elaborata, furono coinvolti alcuni gruppi di giovani architetti italiani e stranieri, accomunati da una spiccata sensibilità per le preesistenze storiche e per le tematiche ambientali; fu loro affidata la stesura di progetti relativi alle nuove destinazioni d’uso delle 15 strutture antiche, ormai in disuso, situate lungo il Torrente Canneto (ex cartiere, ex acquedotti, una ferriera, un saponificio…), sulla base del modello complessivo di sviluppo ispirato alla cultura mediterranea, messo a punto dai geografi. Presso il Laboratorio SIGOT, furono realizzate cartografie di dettaglio delle strutture dismesse e dei vuoti funzionali di tutta la Costiera Amalfitana e della Valle dei Mulini, per la quale fu realizzato un modello tridimensionale in cui furono inseriti i progetti realizzati dagli architetti, nonché alcune iniziative già in atto o in via di definizione a cura degli enti locali, quali il potenziamento del porto di Amalfi, il recupero dei percorsi pedonali nell’area interna, la realizzazione di una strada carrabile lungo la via del Paradiso che attraversa la Valle dei Mulini. Il progetto complessivo fu presentato in occasione del convegno Strategie di valorizzazione territoriale della Costiera Amalfitana: forme innovative di recupero del patrimonio industriale dismesso, organizzato presso la sede della Camera di commercio di Salerno e affiancato dalla mostra La Valle dei Mulini: itinerario progettuale, allestita poi, in modo permanente, presso il Consorzio Osservatorio dell’Appennino meridionale, nel Campus universitario di Fisciano (Amodio, 2003; Riitano, 2011b).Il progetto, ridenominato Waterpower. Renewal Strategy for the Mulini Valley. Amalfi e Scala, ottenne prestigiosi riconoscimenti dalla Holcim Foundation, vincendo due premi internazionali per i progetti di edilizia sostenibile.
2007: Progetto di interesse nazionale Ecosistema urbano: buone pratiche per il governo della sostenibilità urbana e dello sviluppo compatibile. Lo studio riguardò la definizione del Sistema urbano salernitano attraverso la costruzione di una serie di cluster basati su 35 indicatori di efficienza urbana. Furono prodotti numerosi scenari cartografici a livello di sezioni di censimento, utili a delineare e qualificare il sistema urbano oggetto di studio (Riitano, 2007; Bencardino, 2007; Amodio, 2007).
2008: realizzazione Sistema informativo geografico relativo all’individuazione di itinerari turistico/archeologici nell’ambito del Parco del Cilento e Vallo di Diano. Il progetto, finanziato dal POR Campania, era finalizzato a realizzare un WebGIS inteso come un modello di analisi, rappresentazione e valorizzazione dei beni archeologici minori, idoneo a essere esportato nei Paesi terzi del Mediterraneo (Egitto, Marocco, Tunisia, Turchia, Israele) coinvolti nell’ambito del Progetto MATCH (Archeological and Cultural Heritage for the Mediterranean Tourism), così da promuovere azioni di cooperazione territoriale (Cataudella, Riitano, 2008).
2009, progetto impegnativo finanziato da fondi PRIN e dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Salerno. Si trattò di rilevare le discariche di rifiuti solidi urbani dismesse del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al fine di individuarne i fattori di degrado e segnalare la priorità degli interventi necessari per il recupero ambientale dei diversi contesti. Fu messa a punto una metodologia fondata sulla georeferenziazione dei siti e la realizzazione di cartografie relative a ognuno di essi. Utilizzando le tecnologie GIS, le singole discariche furono posizionate sull’ortofoto al 5.000 della Regione Campania (2004) sovrapponendo a essa i layers di interesse della Carta tecnica regionale, la Carta geologica del Servizio geologico d’Italia, la Carta del rischio di frana dell’Autorità di bacino sinistra Sele e la Carta dell’idoneità ambientale della Regione Campania. Successivamente, attraverso la lettura delle cartografie e appositi sopralluoghi, si passò a identificare i fattori di degrado e a individuare la zona di pertinenza delle diverse discariche. Utilizzando le schede di rilevamento appositamente realizzate, in cui a ogni fattore era stato attribuito un punteggio, fu messa a punto una matrice che consentì la realizzazione di una cartografia tematica di sintesi relativa alla distribuzione delle discariche e ai diversi livelli di degrado rilevati, utile al fine di individuare le priorità di intervento. L’apparato cartografico prodotto fu integrato con un’apposita campagna fotografica. Il lavoro, su richiesta dell’Assessorato all’Ambiente, fu inviato a tutti i sindaci dei comuni interessati, costituendo la base per gli interventi di bonifica successivamente realizzati (Riitano, 2009 e 2010).
2010: realizzazione Sistema informativo geografico, finanziato dalla Regione Campania sui fondi della Ricerca scientifica, fu finalizzato all’analisi dei Centri storici beneventani del Parco del Partenio, con l’obiettivo di avviare azioni di tutela, valorizzazione e promozione. La ricerca affrontò lo studio di Arpaia, Forchia, Paolisi e Pannarano, procedendo attraverso puntuali sopralluoghi territoriali, reperimento e analisi di dati, studio della documentazione fornita dai singoli enti comunali e un’apposita campagna fotografica. Infine, l’utilizzo delle tecnologie GIS consentì di evidenziare, nel dettaglio, le caratteristiche strutturali e funzionali dei centri storici, quelle demografiche e socio-economiche, nonché la dotazione di evidenze storico-culturali (Riitano, 2011a).
2012, realizzazione di un WebGIS finalizzato alla promozione e valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali del Mediterraneo, con specifico riferimento al Cilento. L’ottica era sempre quella di mettere a punto un modello capace di favorire lo scambio di esperienze fra i paesi del bacino del Mediterraneo, con finalità di cooperazione su commissione della Vicepresidenza della Regione Campania con delega ai rapporti con i Paesi del Mediterraneo, nell’ambito del Progetto SMALT, Salone Mediterraneo delle Autonomie Locali e dei Territori, commissionò al Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale. Il Sistema informativo fu riferito alla Costiera Cilentana e al suo entroterra, ricco di beni paesaggistici e storico-culturali di rilevante interesse benché pochissimo valorizzati. I diversi percorsi turistici individuati furono resi immediatamente fruibili attraverso la tecnica propria di Google Maps e documentati da una ricca galleria fotografica appositamente realizzata (Cataudella, Riitano, 2012 e 2013).
2014, ricerca sulla qualità ambientale del Comune di Capaccio/Paestum, oltre che il monitoraggio e il controllo di alcune significative filiere agroalimentari su commissione della Camera di Commercio di Salerno dette al Consorzio Osservatorio dell’Appenino meridionale. La ricerca è stata affidata a geografi, chimici e giuristi. Per quanto attiene agli aspetti cartografici è stato coinvolto il Laboratorio SIGOT, mentre le analisi chimiche sono state svolte dal Laboratorio di Chimica dell’Ateneo salernitano. Obiettivo della ricerca è stato quello di misurare la qualità dell’ambiente e la sostenibilità delle numerose produzioni agricole, dell’allevamento bufalino e dell’industria casearia del comune di Capaccio-Paestum. Quest’ultimo è stato considerato un campione adatto a sperimentare una metodologia di analisi, applicabile anche ad altri comuni del Salernitano, che potesse fornire indicazioni attendibili agli enti territoriali oltre che agli imprenditori, ai consumatori e, più in generale, all’opinione pubblica, in merito alla qualità ambientale dei territori caratterizzati dalla presenza di attività agricole intensive e di importanti filiere agroalimentari. La metodologia utilizzata ha previsto, in via preliminare, una lettura disaggregata delle caratteristiche ambientali, per passare poi alla messa a punto di indicatori (determinanti, di pressione, di stato e di risposta) e alla realizzazione di altrettante cartografie tematiche che consentissero un’analisi territoriale di dettaglio e l’individuazione dei punti di prelievo di campionamenti di suolo e di acqua superficiale e di falda, per le previste analisi di laboratorio. Nella fase finale, ottenuti i risultati delle analisi (circa 6.000), si è provveduto a costruire una matrice che permettesse di qualificare le diverse sezioni territoriali in relazione al peso degli indicatori, così da poter realizzare una cartografia di sintesi della qualità ambientale. Quest’ultima ha evidenziato un’ottima situazione complessiva del territorio esaminato (Riitano, 2014; Cataudella, Riitano, 2015 e 2016a). Al contempo, i chimici hanno svolto il monitoraggio e il controllo di alcune importanti filiere agroalimentari, mentre i giuristi hanno effettuato uno studio relativo alla qualità, con riferimento alla protezione dell’ambiente e alla tutela dei prodotti agricoli.
2015: ricerca su commissione del Consorzio Osservatorio dell’Appennino meridionale coinvolse sul patrimonio vitivinicolo della Regione Campania, con riferimento sia alla realizzazione di una cartografia interattiva relativa agli ulivi monumentali della Provincia di Avellino (Amodio, 2016a; Amodio, 2016b), sia allo sviluppo di un portale WebGIS finalizzato alla rappresentazione e valorizzazione degli oli a marchio della Campania. Quest’ultimo, finanziato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione, rientra in un più ampio filone di studi portato avanti dal Consorzio sul tema della dieta mediterranea e dei suoi prodotti. Nello specifico, il portale presentava la produzione olivicola della Campania messa a confronto con quella delle altre regioni del Mezzogiorno, attraverso numerose cartografie in formato raster e vettoriale, relative al sistema agricolo regionale, alla specializzazione olivicola, alle produzioni a marchio. Una sezione è dedicata, poi, alle numerose aziende produttrici di olio DOP della Campania (Riitano, 2016b e 2017a).
2016- 2017 collaborazione al progetto di ampie dimensioni sul centro storico di Salerno, realizzato dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale (DISPAC) in collaborazione con il Centro ICT per i Beni culturali dell’Ateneo, nell’ambito dei Progetti “Cultural Heritage Information System” (CHIS) e “Social Network delle Entità dei Centri Storici” (SNECS), promossi dal Distretto Alta Tecnologia per i Beni Culturali (DATABENC) su fondi PON “Ricerca e competitività”16. Sulla base degli studi sviluppati dalle diverse componenti del Dipartimento, è stata realizzata l’iniziativa Salerno in particolare. Beni culturali e innovazione finalizzata a valorizzare il lavoro di ricerca svolto, rendendolo fruibile per un vasto pubblico. L’evento si è svolto in quattro diverse sedi17 che hanno ospitato iniziative organizzate in una logica di rete, finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Centro storico. Presso la Soprintendenza, è stata allestita la mostra Salerno in particolare. Immagini del Centro storico, articolata intorno a una grande cartografia georeferenziata del Centro storico (7 metri per 4) realizzata con la collaborazione del Laboratorio SIGOT, su cui sono stati geolocalizzati importanti particolari urbani (pavimentazioni, portali, finestre), la cui descrizione poteva essere letta dagli utenti sul cellulare, tramite QR code. Alla grande carta è stata affiancata una galleria fotografica dei 100 particolari selezionati, illustrati da un prezioso catalogo realizzato per l’evento (Trotta, Zuliani, 2017) e una cartografia interattiva, consultabile su un grande schermo touch screen, che consentiva l’individuazione del ricco patrimonio monumentale del Centro storico, classificato per categorie tipologiche, illustrato da schede e da immagini fotografiche (Paladino, 2016).La mostra proponeva una visita virtuale del Centro storico che costituiva un ideale punto di partenza per una visita reale, favorita dalla SmartApp-Salerno per dispositivi mobili, realizzata per l’occasione. Completavano il panorama delle iniziative il video Attraversare Salerno nel tempo. Monumenti, storia, cultura della città, alcune installazioni multimediali che ricostruivano il passato del Centro storico e la storia del suo monumento più rappresentativo, il complesso monumentale di San Pietro a Corte, palinsesto della vita millenaria di Salerno. L’evento è stato arricchito da un ciclo di conferenze, tenute dai docenti del Dipartimento, dal titolo La bellezza dei secoli a Salerno e da un concorso fotografico che ha coinvolto numerose Scuole superiori della città, impegnate in un Progetto di alternanza scuola/lavoro organizzato dal DiSPAC (Amodio, 2017). La mostra, che è rimasta aperta al pubblico presso la sede della Soprintendenza fino alla fine del 2018, è oggi in fase di trasferimento presso l’Ateneo salernitano, dove sarà istallata negli spazi prospicenti l’Aula magna del Campus.
2016: ricerche sviluppate nell’ambito della sezione di “Cartografia e Toponomastica storica”, che ha affrontato problematiche attuali in un’ottica multiprospettica e multiscalare. Tra i temi affrontati emergono alcuni studi sul valore gnoseologico delle fonti geostoriche per la comprensione di dinamiche geopolitiche locali, nazionali e internazionali. Sulla tematica sono stati sviluppate alcune ricerche, condotte in un’ottica diacronica e stratigrafica, sulle dinamiche politiche, presenti e passate, dello sviluppo territoriale di Salerno e della sua provincia interna, attraverso una fonte preziosa come la cartografia aragonese, studiata anche nel suo valore di documento storico e geo-culturale (Siniscalchi, Aversano, 2016).
2016 analisi delle dinamiche relative alla progressiva separazione tra Occidente e Oriente, a partire dalla scomparsa della visione tolemaica dei paesi medio-orientali nella cartografia occidentale e dell’idea del Mediterraneo come “mare nostrum” (Siniscalchi, Palagiano, 2018).
2018 studi che ha richiesto l’impiego di tecniche cartografiche riguarda il complesso concetto di identità territoriale, indagato a partire dalle trasformazioni strutturali di alcuni centri del Salernitano e della città capoluogo. Per quanto riguarda Salerno, una recente indagine (interna a un progetto più ampio, attualmente in corso) ha cercato di metterne a fuoco alcune componenti identitarie attraverso lo studio diacronico delle sue rappresentazioni cartografiche nel corso dei secoli (Siniscalchi, 2018).
2018: studio sull’identità socio-economica dei principali comuni del solco Irno-Solofrana, un’area storicamente strategica, la cui fisionomia negli ultimi trent’anni è stata profondamente modificata dalla presenza del polo universitario di Salerno e di alcune aree di sviluppo industriale e commerciale (Siniscalchi, 2016).
2020: Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su base place evidence, per la valutazione di policy rivolte allo sviluppo della green economy in aree interne e periferie metropolitane. Lo studio si inserisce nel dibattito interno all’Unione Europea sulla coesione territoriale ed è finalizzato ad analizzare le condizioni territoriali a scala italiana, connesse con gli obbiettivi della strategia Europa 2020. Il gruppo di lavoro di Salerno afferente al Laboratorio SIGOT, tenendo conto del quadro metodologico STeMA-TIA tool GIS, si è occupato della Sustainable Growth, Inclusive Growth e Risorse e fondi), rispettivamente declinate in classi di categorie e di indicatori appositamente rilevati, sistematizzati e cartografati, alla scala NUTS 2 e NUTS 3. Ulteriori approfondimenti di indagine verranno effettuati con l’obiettivo di implementare il modello per l’analisi della coesione territoriale nelle sub-regioni italiane, tenendo conto delle aree di interesse prioritario individuate dalla legge Delrio del 2014 (periferie metropolitane) e dai programmi di sviluppo economico relativamente alle aree interne.
Ultimi anni: ricerca commissionata dal Consorzio Osservatorio dell’Appennino meridionale, per la realizzazione di un Portale WebGIS finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale delle aree interne del Cilento. Il lavoro è stato promosso anche dal Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sono stati individuati tre itinerari naturalistico-culturali, il primo nella sezione meridionale del Parco, il secondo in quella mediana, il terzo nell’area orientale, lungo il Vallo di Diano. Una specifica sezione del portale riguarda i numerosi Siti di interesse comunitario (SIC) presenti nell’ambito degli itinerari selezionati (Riitano, 2017b).